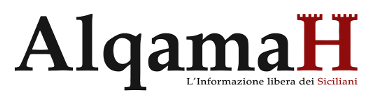L’incredibile storia di Keita: venti giorni nel deserto, un anno e mezzo in Libia passando da un lager all’altro, fino alla quasi resa su un gommone sgonfio e pieno d’acqua nel mar mediterraneo. “L’inferno in Libia non lo dimenticherò mai più. Anche dopo anni, soffro ancora nel rievocare quei momenti. Oggi finalmente sono libero e felice.”

Quella di Keita sembra una storia da film. Una di quelle trame lunghe, ma avvincenti. Se non fosse tutto terribilmente reale, sarebbe una sceneggiatura perfetta. Keita, nome di fantasia, 25 anni, viene da un piccolo paese del Mali. Cresce con i nonni perché la madre non aveva soldi per pagare gli studi a lui e ai suoi fratelli. Inizia a frequentare la scuola per qualche anno, ma sarà costretto ad abbandonarla per iniziare a lavorare con il padre sui campi. Così a 7 anni si ritrova con la schiena piegata a raccogliere riso, mais e arachidi. “Mi piaceva il lavoro in campagna, però volevo continuare a studiare e giocare con i miei amici. Avevo già imparato il francese e stavo iniziando anche l’inglese, ma la mia famiglia non poteva più permettersi la scuola per me”. Anche se ancora molto piccolo, Keita non ci sta a rinunciare alla scuola. Così iniziano i primi dissidi con il padre che lo porteranno ad abbandonare la casa per un breve tempo. “Tornavo a casa ogni tanto, ma le cose non andavano bene”. Fino a quando la minaccia della guerra diventa concreta anche nel loro paese. La vita diventava sempre più difficile per tutti, soprattutto per i bambini. Inizia un brutto periodo, gli animi erano tesi in tutto il Paese. Viene coinvolto in alcune risse tra coetanei. Si ritrova al centro di vicende troppo grandi, viveva nella paura di essere ucciso, con la guerra ormai sotto casa. Non poteva più resistere. L’idea della guerra lo terrorizzava.
 Decide così di andare via e raggiunge prima il Burkina Faso e successivamente la vicina Costa d’Avorio. Lì trova presto una sistemazione e un lavoro, sempre nei campi. Ma dopo cinque anni tra il Burkina Faso e il Paese ivoriano, insieme ad altri ragazzi, decide di raggiungere la Libia per trovare un lavoro e una condizione migliore. Ma era un’illusione. Non aveva mai pensato di raggiungere l’Europa, cercava soltanto un po’ di serenità, una nuova vita. Si era fidato del gruppo di ragazzi e sperava di dare una svolta alla sua vita. Paga dei trafficanti per salire su un vecchio pick-up arrugginito per attraversare il deserto, dal Niger alla Libia. “Eravamo 42 persone, tra uomini, donne e bambini in un piccolissimo fuoristrada. Siamo rimasti bloccati nel deserto per venti giorni. Ho pensato di non farcela.” Keita non avrebbe mai immaginato una cosa del genere. Venti giorni bloccati per un guasto alla macchina, senza campo per chiamare i soccorsi, senza più cibo e acqua. Erano tutti disidratati, stanchi, affamati. “Il deserto ti uccide, soprattutto psicologicamente. Sei in mezzo al nulla, sotto il sole.” Era piena estate e Keita si ritrova con i piedi sulla sabbia rovente del deserto. Passano cinque giorni prima che individuano un punto, dopo molti chilometri percorsi a piedi, per chiamare i soccorsi. Altri interminabili giorni prima che qualcuno li raggiungesse con il pezzo di ricambio. “Ho pensato di morire, di finire come i tanti ragazzi incrociati tra le dune”. Quello che Keita descrive è uno scenario terrificante. Lungo la strada del deserto, tra quelle che non erano vere e proprio strade, ma distese infinite di sabbia, si intravedevano cadaveri. Ovunque. Morti di sete. Morti per il caldo, tra stenti e sofferenze.
Decide così di andare via e raggiunge prima il Burkina Faso e successivamente la vicina Costa d’Avorio. Lì trova presto una sistemazione e un lavoro, sempre nei campi. Ma dopo cinque anni tra il Burkina Faso e il Paese ivoriano, insieme ad altri ragazzi, decide di raggiungere la Libia per trovare un lavoro e una condizione migliore. Ma era un’illusione. Non aveva mai pensato di raggiungere l’Europa, cercava soltanto un po’ di serenità, una nuova vita. Si era fidato del gruppo di ragazzi e sperava di dare una svolta alla sua vita. Paga dei trafficanti per salire su un vecchio pick-up arrugginito per attraversare il deserto, dal Niger alla Libia. “Eravamo 42 persone, tra uomini, donne e bambini in un piccolissimo fuoristrada. Siamo rimasti bloccati nel deserto per venti giorni. Ho pensato di non farcela.” Keita non avrebbe mai immaginato una cosa del genere. Venti giorni bloccati per un guasto alla macchina, senza campo per chiamare i soccorsi, senza più cibo e acqua. Erano tutti disidratati, stanchi, affamati. “Il deserto ti uccide, soprattutto psicologicamente. Sei in mezzo al nulla, sotto il sole.” Era piena estate e Keita si ritrova con i piedi sulla sabbia rovente del deserto. Passano cinque giorni prima che individuano un punto, dopo molti chilometri percorsi a piedi, per chiamare i soccorsi. Altri interminabili giorni prima che qualcuno li raggiungesse con il pezzo di ricambio. “Ho pensato di morire, di finire come i tanti ragazzi incrociati tra le dune”. Quello che Keita descrive è uno scenario terrificante. Lungo la strada del deserto, tra quelle che non erano vere e proprio strade, ma distese infinite di sabbia, si intravedevano cadaveri. Ovunque. Morti di sete. Morti per il caldo, tra stenti e sofferenze.

Keita chiude gli occhi nel ricordare quei momenti, non aveva mai visto una cosa de genere. “Si vedevano spesso ragazzi morti, probabilmente di sete. Io dopo venti giorni nel deserto non riuscivo più a camminare; per circa una settimana ho avuto problemi alla circolazione. Non è stato facile. Un ragazzo che era con me in Libia è stato operato: aveva sabbia nei polmoni”. Quello di Keita è un racconto dettagliatissimo. Duro, ma sincero. Descrive l’orrore dei venti giorni passati nel “deserto della morte” facendo lunghe pause per prendere fiato. Lui parla bene l’italiano e ricorda ogni dettaglio. Anche se pensava e sperava di aver archiviato tutto, decide volentieri di raccontarsi. Siamo seduti davanti un caffè a casa di un suo amico, ogni tanto si blocca, cerca di mettere a fuoco i dolorosi ricordi. “Le ferite bruciano ancora, ricordare queste cose mi fa male, ma lo racconto a voi perché tutti devono sapere quale inferno siamo costretti a passare.” Keita è un ragazzo molto intelligente, ha già sostenuto gli esami per la licenza media e sta studiando per conseguire la patente di guida.
 Tra un sorso di caffè e l’altro, riprende il racconto. Mentre prendo appunti, lui rievoca quei ricordi con l’amico. “Con lui ho affrontato la parte finale del mio viaggio, ci siamo conosciuto sul barcone”, spiega mentre ricomincia a parlare del suo arrivo in Libia. Partito da Agadez, in Niger, arriva a Gatron, in Libia. Si tratta di una della più trafficate rotte migratorie. Gatron è un vero e proprio bivio di smistamento dei migranti in arrivo dai paesi sub-sahariani. Il gruppo viene immediatamente bloccato da militari armati. Dovevano pagare se volevano oltrepassare il “posto di blocco”. Senza soldi, l’unica alternativa era finire in un carcere libico. Per Keita inizia un nuovo inferno, un giro interminabile lungo un anno e sei mesi dentro alcuni centri di detenzione. “Ci hanno portati in una grande casa, non era un vero carcere. Eravamo circa 25, ricordo 5 donne e 2 bambini. Ogni mattina venivano a guardarci, a sceglierci come schiavi.” Keita, come molti altri, diventa uno schiavo. Prelevato la mattina per andare a lavoro e riportato al centro di detenzione la sera. Lui non stava bene, il lungo viaggio nel deserto lo aveva debilitato e soffriva molto. Veniva scelto, o scartato, in base al bisogno del padrone di turno: lavori in campagna, lavori edili, come ragazzo delle pulizie. Senza ricevere un soldo. Lui era uno dei più piccoli e dei più deboli, ma molti altri, quelli che cercavano di opporsi prendevano bastonate. Ogni giorno. Le urla di quei ragazzi non riesce a togliersele dalla mente. Se chiude gli occhi sente ancora il rumore del legno sulla schiena, sulla carne. “Erano momenti durissimo da affrontare. Se chiudo gli occhi ricordo ogni particolare. Non avrei mai pensato di dover vivere in quelle condizioni, volevo tornare a casa, fuggire da lì. Ma non avevo nessuna possibilità di fuga”. Finché non gli affidano un lavoro piuttosto semplice: portare da mangiare a delle capre. Dopo un paio di giorni passati a studiare il luogo esterno alla casa, il terzo giorno decide di fuggire sfruttando la posizione defilata del’ovile. Corre veloce verso un boschetto fino a raggiungere una strada.
Tra un sorso di caffè e l’altro, riprende il racconto. Mentre prendo appunti, lui rievoca quei ricordi con l’amico. “Con lui ho affrontato la parte finale del mio viaggio, ci siamo conosciuto sul barcone”, spiega mentre ricomincia a parlare del suo arrivo in Libia. Partito da Agadez, in Niger, arriva a Gatron, in Libia. Si tratta di una della più trafficate rotte migratorie. Gatron è un vero e proprio bivio di smistamento dei migranti in arrivo dai paesi sub-sahariani. Il gruppo viene immediatamente bloccato da militari armati. Dovevano pagare se volevano oltrepassare il “posto di blocco”. Senza soldi, l’unica alternativa era finire in un carcere libico. Per Keita inizia un nuovo inferno, un giro interminabile lungo un anno e sei mesi dentro alcuni centri di detenzione. “Ci hanno portati in una grande casa, non era un vero carcere. Eravamo circa 25, ricordo 5 donne e 2 bambini. Ogni mattina venivano a guardarci, a sceglierci come schiavi.” Keita, come molti altri, diventa uno schiavo. Prelevato la mattina per andare a lavoro e riportato al centro di detenzione la sera. Lui non stava bene, il lungo viaggio nel deserto lo aveva debilitato e soffriva molto. Veniva scelto, o scartato, in base al bisogno del padrone di turno: lavori in campagna, lavori edili, come ragazzo delle pulizie. Senza ricevere un soldo. Lui era uno dei più piccoli e dei più deboli, ma molti altri, quelli che cercavano di opporsi prendevano bastonate. Ogni giorno. Le urla di quei ragazzi non riesce a togliersele dalla mente. Se chiude gli occhi sente ancora il rumore del legno sulla schiena, sulla carne. “Erano momenti durissimo da affrontare. Se chiudo gli occhi ricordo ogni particolare. Non avrei mai pensato di dover vivere in quelle condizioni, volevo tornare a casa, fuggire da lì. Ma non avevo nessuna possibilità di fuga”. Finché non gli affidano un lavoro piuttosto semplice: portare da mangiare a delle capre. Dopo un paio di giorni passati a studiare il luogo esterno alla casa, il terzo giorno decide di fuggire sfruttando la posizione defilata del’ovile. Corre veloce verso un boschetto fino a raggiungere una strada.

Nel primo villaggio trova qualcuno che organizza delle staffette per Tripoli. Pensava potesse essere un buon posto per fuggire da quell’inferno. Ma il primo viaggio per Tripoli fallisce. Il furgone viene avvisato di controlli sulla strada e torna indietro. Al secondo tentativo però raggiunge Sebha. Per quattro mesi ha vissuto in un appartamento con altri ragazzi, lavorando come muratore e imbianchino. Mette un po’ di soldi da parte e raggiunge finalmente Tripoli, ma viene subito arrestato e portato in una prigione. Un accampamento gigantesco, che Keita non aveva mia visto prima. Non era come il precedente. Si rende conto subito di essere finito in una grande prigione per i rimpatri. “Venivamo trattati come gli animali, ci buttavano il pane come si fa con le bestie e non tutti riuscivano a prenderlo. Valeva la legge del più forte”. Keita si ritrova tra migliaia di ragazzi pronti per essere rimpatriati dal Governo libico. Ci resterà per parecchi giorni. Ogni giorno portavano altri uomini, donne e bambini prelevati da Tripoli e da altre città. “Ricordo un signore portato al centro ancora sanguinante. Forse colpito da un colpo di arma da fuoco, dicevano che aveva subito un intervento chirurgico, ma perdeva molto sangue”. All’interno del centro venivano raggruppati per nazionalità e inseriti in una lista per il rimpatrio. Ma il giorno prima di essere prelevati per il rimpatrio, per alcuni ragazzi, tra cui Keita, viene deciso lo spostamento in un alto centro, a Zabrata. Erano stati venduti, almeno questo è quello che oggi sospetta Keita, ad altre organizzazioni criminali. “Per loro eravamo schiavi da sfruttare: chiedere il riscatto a casa o lavorare fino alla morte. Farci rimpatriare per loro non sarebbe servito a nulla.” Così ricomincia da zero. Una settimana di stenti nell’ennesimo carcere libico. Bastonate, lavoro, richieste di riscatto. Il copione non cambia. “Chi riusciva a lavorare era più fortunato, per gli altri erano problemi. In quei centri si muore di fame e per le violenze, nell’indifferenza generale. L’essere umano viene annullato, ridotto a carne da macello da sfruttare per soldi.” Era la Libia del dopo Gheddafi. È la Libia di oggi: un Paese ancora in guerra che continua a macchiarsi di orrori indicibili. Deportazioni, mutilazioni, torture, richieste di riscatto, violenze sessuali, in poche parole: Crimini contro l’umanità. Era la Libia di 10 anni fa, è la Libia di oggi. Cambiano i conflitti, ma non le violazioni dei diritti umani.

“Il cibo dei carcerati era sempre lo stesso: pane e acqua. Ero diventato magrissimo e pensavo di non farcela a superare l’ennesima prigione”. Ma accadde un altro fatto incredibile. Una mattina vengono stipati, come bestie, su un camion per essere condotti in un centro in Niger (almeno così aveva capito), il vecchio centro non era più sicuro. Ma lungo la strada, nel deserto, alcuni uomini su delle auto affiancarono il camion per prendere alcuni prigionieri. “Sotto la minaccia delle armi hanno costretto alcuni dei ragazzi a lanciarsi dal camion in corsa”. Anche Keita si lancia. Se la cava con qualche graffio e un paio di ematomi. Viene portato a casa di un uomo che lo usa come schiavo. Doveva pulire, lavare, fare dei lavori di casa, lavorare la terra. Keita fugge dopo appena 3 giorni e raggiunge un piccolo paese vicino. Trova l’ennesimo passaggio per Tripoli, nascosto dentro un pick-up. A Tripoli viene assunto da alcuni cinesi. Lavorava in un cantiere, si occupava di idraulica insieme ad altri ragazzi. Fino a quando, mentre si trovava in strada con un amico, viene fermato da due uomini con una finta divisa della polizia. Keinta ne era sicuro, non erano poliziotti. Sotto la minaccia delle armi viene portato per l’ennesima volta in un carcere insieme ad altre 15 persone. Uno dei carcerieri lo porta a lavorare a casa della madre. Anche lì si doveva occupare delle pulizie. Ma anche loro non lo pagavano e non aveva molte possibilità di fuga. Finché un giorno quella signora, vedendolo giovanissimo e sofferente, gli confida che non aveva scelta: tornare in prigione o decidere di partire per l’Europa. Un loro conoscente organizzava dei viaggi per l’Italia, se avesse lavorato ancora per loro gli avrebbero garantito un viaggio su uno dei “barconi della speranza”. Keita non aveva altra scelta, non voleva più tornare in un carcere. Decide di accettare e dopo qualche settimana di duro lavoro raggiunge il mare. Lì conosce un ragazzo maliano come lui che diventerà il suo migliore amico in Italia.

“Eravamo circa 120 su quella spiaggia. Abbiamo visto con i nostri occhi i libici che gonfiavano un grosso gommone. Erano le quattro del mattino. Hanno fissato delle tavole di legno con dei bulloni per farci appoggiare i piedi e per sistemare il motore.” Keita e l’amico salgono con tutti gli altri, con loro anche 12 bidoni di benzina e un ragazzo incaricato di controllare la bussola. Ma il gommone si buca subito, erano troppi. I libici fanno scendere una ventina di ragazzi e riparano con della colla e del materiale plastico il gommone e lo fanno partire. “Eravamo spaventatissimi, quel gommone non era per niente sicuro. Eravamo circa 85 persone, tutti disperati e impauriti.” A bordo anche una bombola d’aria per gonfiare il gommone, ma nessuno la sapeva usare. Il giovane incaricato di controllare la bussola non riusciva a trovare la strada, era spaventatissimo. Si perdono e sbagliano rotta. Dopo una ventina di ore si ritrovano senza più benzina, senza aria nella bombola per gonfiare il gommone che nel frattempo iniziava a sgonfiarsi lentamente. Anche l’acqua iniziava ad entrare. In pochi minuti a bordo il panico prende il sopravvento. Le onde del mare si facevano sempre più grosse e li spingevano a largo. Le onde cullavano il gommone, tra pianti disperati e preghiere strazianti. Non sapevano se erano diretti verso la Tunisia o verso Lampedusa. Erano totalmente in balìa delle onde del mare. Keita sapeva nuotare, ma era terrorizzato da qual mare nero come la notte. Ormai bagnato, con l’acqua che continuava a salire, si spoglia e resta in mutande. “Ho pensato che in caso il gommone si fosse capovolto, senza i vestiti, avevo qualche speranza in più di restare a galla e nuotare, magari per potermi aggrappare a qualcosa”. Resta così aggrappato al tubolare del gommone nel buio della notte, ormai senza speranze. L’amico invece era disperato, non sapeva nuotare. “Quella sera ho pensato di morire. Sono rimasto per qualche ora aggrappato a quel gommone mezzo sgonfio, tra le urla dei miei compagni di viaggio, il freddo della notte e la speranza che si affievoliva lentamente.”

Dopo qualche ora sarà una nave militare a recuperare il loro gommone mezzo affondato. “Alla vista della nave abbiamo rischiato di capovolgerci, perché alcuni pensavano fossero i libici. Preferivamo morire in mare piuttosto che essere riportati indietro. Immediatamente ci hanno rassicurati che erano italiani.” Bagnato, senza vestiti, denutrito, disidratato. Ma vivo. Così come il suo amico. Keita sbarca a Trapani dopo due giorni dal salvataggio. Ancora non aveva realizzato di essere finalmente salvo da quell’inferno.
Scendono tutti e due scalzi dalla nave. “Non appena abbiamo visto il porto, senza uomini armati ad aspettarci, abbiamo realizzato che il peggio era davvero passato.” Finalmente sorridono. Si guardano, si abbracciano. L’orrore lascia lo spazio alla speranza. La sofferenza all’amicizia ritrovata. La Libia un brutto ricordo, l’Italia un nuovo inizio.
Dopo un breve periodo in un centro di accoglienza di Trapani i due amici si separano, ma restano in contatto. “Dalla mia fuga dal Mali avevo sentito mia madre una sola volta durate una delle tante fughe dal cercare. Lei era disperata ed era sicura che non mi avrebbe più rivisto. Non appena sono arrivato in Italia sono riuscito a richiamarla. È stato il mio primo pensiero. Di me non aveva notizie da oltre un anno. Mi credeva morto. Oggi è felicissima della mia nuova vita in Italia e ci sentiamo spesso. Con lei ci sono i miei fratelli più piccoli”.  Oggi Keita vive in un paesino dell’entroterra trapanese, ha un lavoro stabile, una casa con regolare contratto d’affitto, ha studiato, frequenta la scuola guida e ha partecipato a molti progetti di integrazione. “Qui in Italia e a Trapani sto bene; sto costruendo il mio futuro e vorrei creare una mia famiglia. Sono tornato a lavorare in campagna, del resto è sempre stato il mio lavoro. Però qui mi pagano regolarmente, ho un contratto e finalmente i documenti. In Mali? Non posso tornare, non ho più nulla. Tornerei soltanto per riabbracciare mia madre. Qui posso studiare e vivere felice, senza conflitti. Non riesco ad immaginare il mio futuro lontano dall’Italia. Sono partito per un solo motivo: essere felice”. Dopo qualche anno in giro per l’Europa, l’amico decide di tornare nel paese del trapanese per lavorare vicino a Keita. Alla fine della lunga storia, l’amicizia è il sentimento che più emerge in una storia terribile, ma che meritava di essere raccontata. Il loro legame, nato su un gommone alla deriva, oggi rappresenta il loro punto di forza.
Oggi Keita vive in un paesino dell’entroterra trapanese, ha un lavoro stabile, una casa con regolare contratto d’affitto, ha studiato, frequenta la scuola guida e ha partecipato a molti progetti di integrazione. “Qui in Italia e a Trapani sto bene; sto costruendo il mio futuro e vorrei creare una mia famiglia. Sono tornato a lavorare in campagna, del resto è sempre stato il mio lavoro. Però qui mi pagano regolarmente, ho un contratto e finalmente i documenti. In Mali? Non posso tornare, non ho più nulla. Tornerei soltanto per riabbracciare mia madre. Qui posso studiare e vivere felice, senza conflitti. Non riesco ad immaginare il mio futuro lontano dall’Italia. Sono partito per un solo motivo: essere felice”. Dopo qualche anno in giro per l’Europa, l’amico decide di tornare nel paese del trapanese per lavorare vicino a Keita. Alla fine della lunga storia, l’amicizia è il sentimento che più emerge in una storia terribile, ma che meritava di essere raccontata. Il loro legame, nato su un gommone alla deriva, oggi rappresenta il loro punto di forza.
Foto di copertina: Mediterranea Saving Humans, 2019.