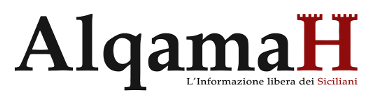I racconti di Nicola Quagliata
I racconti di Nicola Quagliata
Anniria scoprì il suo talento da adolescente.
La Sicilia, la sua famiglia ed il periodo storico incerto del dopoguerra, su quel talento in lui costruirono una vocazione.
Quel gioco iniziato da ragazzo non lo abbandonò da grande perfezionandolo, sparo dopo sparo, come suo lavoro, e non c’è nulla di più bello nella vita del poter fare di un gioco il lavoro.
Un mattino, come se rispondesse ad un richiamo, tenne d’occhio sua madre e quanti frequentavano la sua casa in campagna, e lo fece senza sapere bene il perché.
Se ne stava solarino, scontroso con la fronte aggrottata e lo sguardo di traverso, appariva addirittura minaccioso.
Lui stesso si sentiva inquieto, non rivolgeva la parola a nessuno, nemmeno per un saluto, i cani gli si mantenevano lontani e non avevano ricevuto alcun richiamo, abituati ai suoi scherzi ed alle sue provocazioni giocose, sempre pronti ad attaccarsi coi denti ai suoi pantaloni, si allontanavano verso la ficara, per godersi almeno un poco d’ombra, e di brezza marina.
I suoi pensieri non erano minacciosi, guardava intorno a sé ed era come se annotasse con la mente quel che vedeva, freddamente; il tavolo grande al centro della stanza e le sedie una di fianco all’altra, di legno scuro, robuste, e le sedie impagliate con gli schienali a muro nella disponibilità di quanti avrebbero voluto sedervisi, sul tavolo una caraffa d’acqua bianca con onde bluastre dipinte e delfini grigio chiaro, ed un centro tavola di merletto bianco, con scene gentili ed eleganti di caccia al cervo, con uno dei cervi colpito da una freccia e sanguinante, sopra al centro tavolo un cesto di canna intrecciato con tralci di olivo con dentro mele, pirazzola, uva da tavola, qualche granato.
Ad un certo momento della mattinata, quando fu sicuro di poter agire non visto, scattò verso il panaro di canna sopra uno sgabello di fella, dentro uno stanzino buio, senza finestre, con la porta di legno semichiusa.
Anniria sapeva che in quel panaro suo padre ci teneva le cartucce che era bravo a preparare nei suoi rientri dal confino a Favignana, e che anzi erano le uniche cartucce di cui diceva di potersi fidare sia per la caccia che per altro; infilò entrambe le mani nel panaro e ne afferrò cinque mettendosele dentro la camicetta.
Avvertì il freddo al contatto con la pelle e corse nella stalla dove al lato della mangiatoia stava appeso un fucile detto a canna liscia, a colpo singolo, che suo padre diceva che era dell’800 ed era appartenuto a suo nonno.
Anche se era del secolo precedente per chi aveva buona mira quell’unico colpo era sufficiente.
Lo prese sganciandolo dal chiodo ed attento a non farsi scorgere da nessuno si allontanò dentro al vigneto dove, dentro i filari, le foglie verdi e ramate, seppure rade, lo coprivano e lo nascondevano alla vista; lui era basso come le vigne legate alla alcamese, senza la canna di sostegno.
Attraversò il vigneto con il legno liscio e morbido del fucile tra le mani, non gli pesava e riusciva a reggerlo anche con una sola mano, ma lui voleva portarlo a tracolla, con la canna rivolta verso l’alto.
All’ultimo filare di vigne, sentendosi al sicuro, si fermò per meglio guardare il suo fucile finalmente da vicino, ora che lo teneva tra le mani, e poterlo finalmente mettere a tracolla ed andare per le campagne a sparare.
 Dove il vigneto finiva, davanti a lui, sul lato del mare e dei faraglioni in lontananza, un muro di pietra a secco limitava la finaida (il confine) con la proprietà vicina con mandorli e ulivi bassi secolari; dal muro di pietre sporgeva il tronco di un melograno i cui rami carichi di granati maturi pendevano e si adagiavano tra le pietre del muro, di fianco al melograno, sempre sul muro di pietra, una intricata vegetazione di alivastro, spinapuci e spine sante formava una macchia impenetrabile ed una barriera invalicabile.
Dove il vigneto finiva, davanti a lui, sul lato del mare e dei faraglioni in lontananza, un muro di pietra a secco limitava la finaida (il confine) con la proprietà vicina con mandorli e ulivi bassi secolari; dal muro di pietre sporgeva il tronco di un melograno i cui rami carichi di granati maturi pendevano e si adagiavano tra le pietre del muro, di fianco al melograno, sempre sul muro di pietra, una intricata vegetazione di alivastro, spinapuci e spine sante formava una macchia impenetrabile ed una barriera invalicabile.
Anniria non aveva mai fatto caso al melograno, che in quel punto non si distingueva dal resto della vegetazione ed era un angolo che non aveva mai frequentato né per gioco né per altro.Vide tra i rami del melograno, intorno ad un granato spaccato ed aperto come la ferita sulla costola del Cristo in una immagine sacra dipinta in una edicola lì vicino, un giovane merlo dalle piume nere e lucenti, col becco giallo che sembrava d’oro, che muovendo il collo a scatti dentro la feritoia del frutto, ne estraeva diligentemente i grani maturi abbrunati, e con avidità, dalla punta del becco giallo che rivolgeva verso il cielo, li lasciava cadere in gola con i suoi scatti. Sembrava che giocasse. Aprendo del tutto il becco li ingoiava rivolgendo poi, con altro scatto, il suo becco dorato dentro al granato.
Senza pensarci Anniria liberò il fucile che ora teneva a tracolla, lo spezzò infilando nella canna la cartuccia che prelevò dalla camicia, richiuse l’arma e sparò al merlo tra i rami del folto melograno.
Sentì lo sparo ed il fruscio dei pallini di piombo tra le foglie, come un vento forte e rapido, e vide quel vento colpire, più in là, il tronco di un mandorlo, portandogli via la corteccia come con un morso veloce, e perdersi più oltre tra le foglie di un ulivo carico di frutto maturo.
 Non vide più il merlo, ed alcuni granati che erano stati attraversati dal piombo, ora gocciolavano squarciati sulle pietre del muro, gocciolavano senza il ricordo dello sparo, come se avessero gocciolato da sempre, e nel silenzio che era ritornato più forte di prima si sentivano gli uccelli cinguettare e rincorrersi nell’aria e sugli alberi, ed una coppia di gazze bianche e nere avevano ripreso a saltellare giocose attorno ai tronchi degli ulivi oltre la finaida.
Non vide più il merlo, ed alcuni granati che erano stati attraversati dal piombo, ora gocciolavano squarciati sulle pietre del muro, gocciolavano senza il ricordo dello sparo, come se avessero gocciolato da sempre, e nel silenzio che era ritornato più forte di prima si sentivano gli uccelli cinguettare e rincorrersi nell’aria e sugli alberi, ed una coppia di gazze bianche e nere avevano ripreso a saltellare giocose attorno ai tronchi degli ulivi oltre la finaida.
Come se lo sparo non ci fosse stato.
Il merlo era caduto morto sul muro.
Nella caduta era scivolato in una cavità tra due pietre sghimbesce che non avevano ben aderito tra loro al momento della posa, o si erano smosse col tempo e col passaggio di pecore e capre.
Nel cadere dentro l’anfratto aveva attraversato una ragnatela tra le pietre, squassandola, e il ragno, di quelli enormi, si era da subito attivato per la ricomposizione della sua tela.
Il becco giallo del merlo rivolto verso l’alto spiccava nel buio della gola di pietre. Anniria aveva le spalle al sole, – che illuminava, tra gli arbusti di Passo Sataro, le macchie di disa, l’alivastro ed il sommacco ed il sorbo e le spine sante, e sollevandosi nel cielo accorciava le ombre fino ad entrare nella valle di Guidaloca, riflettendosi sulla poca acqua che in quel periodo vi scorreva scendendo da monte Inici per Vuccacinturino e Fraginesi fin dentro la fiumara – e davanti a sé il mondo era limpido e chiaro e ben visibile il tracciato dello sparo, fatto di granati colpiti a sangue che sgocciolavano, rami spezzati e sfrantumati, foglie stracciate, il tronco del mandorlo morsicato dal piombo e le olive mature tritate insieme alle foglie dei rami bassi piegati verso terra.
Ma il suo sguardo, fiero del risultato raggiunto con un sol dito della mano, cercava curioso il merlo chiedendosi che fine avesse fatto e come aveva potuto accorgersi del pericolo e volare via più velocemente dello sparo.
Il merlo stava davanti a lui intento a prelevare grani maturi, cristallini e succulenti dal granato, felicemente li ingoiava mostrandoli al cielo ignaro del mondo; Anniria aveva premuto il dito sul grilletto e dopo l’attimo dello sparo, che per altro aveva colto anche lui di sorpresa, il merlo era sparito.
D’istinto corse verso il muretto per guardare da vicino la sua fucilata e toccare con mano i cambiamenti che aveva prodotto e con un salto salì in piedi sul muretto, sulle pietre accanto al melograno, abbassò lo sguardo nel punto in cui gocciolava il granato e si abbassò per bagnarsi le dita ed assaggiarne il sapore, nell’abbassarsi scorse il becco dorato del merlo dentro alla fessura tra le due pietre più grandi e scosse, e vide la ragnatela che pendeva come uno straccio tra le pietre e il ragno che si agitava sulla tela che penzolava.
Quel ragno, grande quanto un pugno chiuso, lo separava dal suo merlo; suo dal momento che lo aveva ucciso, suo perché avendolo ucciso se ne era appropriato; l’atto dell’uccisione per Anniria coincideva con quello della appropriazione, lui aveva sparato ed il merlo era morto ed ora era suo.
Quel ragno doveva sparire perché lui potesse prenderlo e portarselo via, ma Anniria aveva paura del morso del ragno. Le pietre dei muri erano abitate anche dal serpe nero che vi trovava crastuna e babbaluci da mangiare, e il serpe nero spaventava Anniria fino al terrore, ma se c’era il ragno e la ragnatela non c’era la visina (il serpe), non c’era il suo passaggio.
Doveva ammazzare il ragno per arrivare al merlo e poterselo portare via. Il ragno non abbandona facilmente la sua tela e non se ne allontana per “scanto”, questo Anniria sapeva, che non lo avrebbe mai “scantato” e sapeva che il ragno sulla terra ferma riesce a muoversi con grande rapidità e lui aveva orrore che potesse saltargli sui piedi e quindi salirgli sulle gambe.
Non era facile liberarsi del ragno, ucciderlo non era semplice, poteva sempre nascondersi tra le pietre del muro e mordergli la mano mentre prendeva il merlo.
Saltò giù dal muretto, poggiò il fucile con la canna in aria su uno zucco di vite e sradicò il tronco secco di una fella robusta, ottenendone un bastone agevole, saltò nuovamente sulle pietre sul muretto e vide il ragno come prima, e di là del ragno, nel buio delle pietre sul muro, il becco giallo del suo merlo. Con la punta del bastone bloccò il ragno sulla pietra e premette per schiacciarlo, si appiccicò alla punta della fella e Anniria rise e lanciò lontano il bastone ed il ragno, dove le laboriose formiche lo avrebbero fatto sparire, facendone provviste per l’inverno. Infilò la mano nel buco e prese finalmente il merlo per il becco, con le dita, ma gli scivolò via cadendo più in fondo nel muretto, allora infilò il braccio fino a raggiungere quella sua proprietà e l’afferrò per un’ala , finalmente la tirò fuori e poté guardarla da vicino, tenendola tra le mani. Prese il merlo per il collo tenendolo appeso e facendolo dondolare, riprese il fucile e con entrambe le mani piene, si avvio verso casa, al centro di Passo Sataro.
Aveva ammazzato il merlo e ne era diventato proprietario.
Il mondo era entrato in guerra e le nazioni che avrebbero vinto la guerra diventavano proprietarie di tutti i beni di quelle altre nazioni che la perdevano, e potevano ridurre in schiavitù i vinti; suo padre di ritorno dal confino a Favignana per la vendemmia, aveva detto che l’Italia e la Germania erano alleati e si preparavano a una guerra mondiale, che la Germania che l’anno prima a settembre aveva invaso ed occupato la Polonia, a giugno aveva occupato col proprio esercito pure la Francia dopo che l’Italia gli aveva dichiarato guerra. In Italia facevano credere che si trattava di una passeggiata, ma quella sarebbe stata una guerra più sanguinosa della prima guerra mondiale, con milioni di morti e città distrutte. Suo padre queste cose le apprendeva ascoltando i ragionamenti dei confinati politici tra Favignana, Lampedusa, Ustica, Pantelleria, dove scontava il suo confino per mafia, condannato per un conflitto a fuoco coi carabinieri di Balata di Baida vent’anni prima. Nella sparatoria lui era rimasto ferito alla spalla, e due carabinieri uccisi.
Lo presero e lo processarono, il suo avvocato riuscì a dimostrare che non aveva sparato lui i colpi mortali, ma certi altri che erano riusciti a fuggire e che lui non conosceva. Gli diedero sette anni di carcere e poi il confino.
Al confino riusciva sempre a farsi trasferire da un’isola all’altra e così le girava tutte, e conosceva tutti i confinati politici da cui c’era da apprendere molto, perché erano tutti professoroni, carichi di letture e di libri, e le cose le capivano anche perché riuscivano a mantenere i contatti con tutto il mondo, soprattutto con la Russia, e sapevano tutto quel che succedeva e che doveva succedere.
I suoi rientri a casa erano sempre di contrabbando. Riusciva ad allontanarsi dal confino con la complicità delle guardie, e sempre vi rientrava come concordavano.
La rete di complicità e accondiscendenze, che permetteva a Vincenzo M. di allontanarsi dalle isole, e dal luogo dove era tenuto al confino, ogni qualvolta che ne aveva necessità, gli consentiva di mantenere la gestione dei suoi feudi e delle sue masserie. I tre feudi che possedeva, oltre ad appezzamenti più piccoli di terreni, si trovavano in località diverse e tutte nelle pianure intorno, ed a valle, di Monte Inici, per decine e decine di ettari, con bagli, macaseni e stalle.
In un feudo con baglio e ampie stalle aveva un allevamento di oltre duecento mucche, più i vitelli che vendeva per la carne, con decine di ettari di terreno a pascolo.
Nello stesso baglio si producevano i formaggi che venivano venduti all’ingrosso a commercianti del nord.
Degli altri due feudi uno era a vigneto ed uno ad uliveti. I piccoli appezzamenti di terreno li dava in affitto a coloni e mezzadri o a gabella evitandone la gestione diretta perché troppo dispersiva ma curando e controllando personalmente che il fittavolo rispettasse gli obblighi contrattuali quando l’accordo prevedeva lavori di sistemazione e riparo delle terre, degli argini dei torrenti e dei ruscelli, delle terre scoscese, dei muri in pietra, dei macaseni, e controllando anche il rispetto degli obblighi di concimazione e la piantumazione di alberi da frutto; tutto questo gli consentiva di essere presente nella vita di centinaia di famiglie e di costruire il consenso sociale che riteneva dovesse accompagnare intimamente la proprietà.
Per l’allevamento delle mucche – per il quale lo avevano soprannominato con disprezzo lu vaccaru – e la produzione di formaggi, aveva due distinti curatoli che pagava come annalori, e come annalori venivano pagati i guardiani dei pascoli e delle stalle, e cosi pure i casari.
I curatoli erano uomini di assoluta fiducia, e tre di loro avevano fatto giuramento di sangue, ed erano entrati nella famiglia di Vincenzo M. come uomini d’onore, erano stati vattiati, ribattezzati, giurando fedeltà alla famiglia.
Altri quattro curatoli erano impegnati nella vite e nella produzione del mosto e negli uliveti e nel frantoio e nella produzione dell’olio. I curatoli che non erano entrati nella famiglia sapevano bene dove si trovavano e con chi avevano a che fare, ma loro badavano al loro lavoro ottenendo il rispetto che si conquistavano. Tutti i contadini e lavoranti che si muovevano dentro i feudi di Vincenzo M. e nelle sue masserie, sapevano cosa veniva loro richiesto, prima di ogni altra cosa, che non era previsto in nessun contratto ma che agiva con una forza superiore a quelle previste negli accordi scritti, agendo come un vero e proprio tabù.
La lingua tagliata, mozza, chiusa strettamente tra i denti, il silenzio su ogni cosa che vedevano, il silenzio prima di tutto, ed era sulla base di questa virtù che veniva selezionata la forza lavoro bracciantile, ed ogni altra qualifica come i potatori e gli stessi vendemmiatori e raccoglitori di olive, così i fittavoli ed i piccoli gabelloti cui dare la terra da lavorare, silenzio ed omertà su ogni cosa.
Chiunque entrava nelle proprietà di Vincenzo M. poteva vedere cose che non doveva vedere, a cominciare dallo stesso Vincenzo M. che invece di stare al confino nelle isole andava avanti e indietro nei suoi feudi, e spesso in compagnia di altri latitanti. O poteva vedere bestie che non dovevano stare i quei luoghi perché in quelle terre si dava rifugio agli animali, buoi soprattutto, rubati in altri luoghi da amici e che venivano macellati e smerciati come carne fresca, oppure imbarcati vivi per altre località del Mediterraneo.
Per questo nessuno doveva vedere, se qualcuno vedeva era un folle indicato come folle da tutti e non avrebbe più trovato lavoro, ed in casi estremi andava incontro a incidenti mortali perché anche una sola parola di troppo non doveva essere tollerata, a tal punto che silenzio ed omertà diventavano una rigida regola sociale, e nel caos delle gerarchie dei processi produttivi, dove la struttura aziendale era costituita da pochissime figure professionali, come i curatoli che stavano al vertice della organizzazione, e pochissimi boari stabili e casari, con tutto il resto della forza lavoro che veniva assunta a giornata, comprese anche le qualifiche come i potatori, con estrema precarietà del lavoro e massimo arbitrio nella assunzione, i valori, le credenze, le gerarchie si proiettavano fino nell’angolo più remoto e buio delle abitazioni, così da diventare anche credenze e gerarchie sociali, e ciò che veniva messo in discussione negli ambiti lavorativi dissestava l’intero ambito sociale, data la coincidenza tra ambito sociale e lavorativo, tra vita privata e lavorativa, e il dissesto poteva sempre spingersi su quello che c’era di più sacro, la proprietà, come era successo con gli scioperi e le occupazioni delle terre nel 1919 e che solo l’avvento del fascismo riuscì a bloccare.
La proprietà che andava conquistata con la forza andava difesa con la forza, oltre i confini di competenza dello stato, e per Vincenzo M. la forza era data per metà dalla proprietà stessa e per metà dal consenso sociale.
Nelle sue masserie impegnava ben sei curatoli ed un sotto curatolo per il trattamento dei formaggi.
– Due curatoli ed un sotto curatolo per l’allevamento e la produzione e vendita della carne dei vitelli e dei formaggi,
– due curatoli per la coltivazione dei vignati e la produzione e vendita del mosto e del vino,
– due curatoli per la produzione e vendita dell’olio compresa la gestione di un frantoio.
Non tutti i suoi curatoli erano uomini d’onore della famiglia, quelli che non lo erano apportavano un contributo in più di consenso, perché gestivano un enorme potere, ed avevano nelle loro mani il destino e la vita di decine di famiglie, quindi un enorme potere sociale.
In tutto questo il potere economico e sociale di Vincenzo M. era enorme e riconosciuto al punto che nonostante avesse avuto un provvedimento di polizia come il confino se ne poteva allontanare quando voleva, ma nullo era il suo potere e riconoscimento politico.