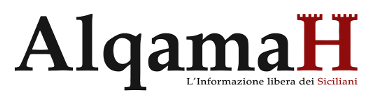Una interminabile ferita lunga 45 anni. Il Belice che nel 1968 trema mettendo ferite su ferite già esistenti. La povertà, il degrado, l’abbandono che già devastava questa terra, martoriati da un terribile terremoto, era il 15 gennaio 1968. Un solco profondo rimasto ancora oggi non colmato, sporco di tanto sangue, le vittime del sisma e a seguire il sangue dei morti ammazzati per consentire alla mafia di affondare le sue mani nell’affare ricostruzione. Dentro al post terremoto ci sono le faide, le vendette, gli scandali, ancora oggi più o meno risolti o rimasti avvolti nel mistero, come d’altra parte sono rimasti certi omicidi che hanno avuto come scenario intrallazzi, gli affari illeciti, e, per l’appunto anche i delitti. Come quello dell’ex sindaco di Castelvetrano Vito Lipari, ucciso il 13 agosto del 1980. Un delitto rimasto senza colpevoli e senza movente. Mauro Rostagno dagli schermi di Rtc non perdeva una sola delle udienze del primo processo per il delitto Lipari, quello che vedeva imputato il capo mafia di Mazara Mariano Agate assieme a boss catanesi: fu durante una pausa di una udienza di questo dibattimento che Agate mandò a dire, da dentro la gabbia, che Rostagno «doveva dire meno minchiate» sul suo conto. Rostagno continuò a parlare di quel processo e a ricostruire le trame della mafia belicina. Qualche mese dopo Rostagno fu ucciso. La sua morte fu decisa a Castelvetrano da don Ciccio Messina Denaro. Rostagno era una “camurria” e quindi andava ammazzato, don Ciccio Messina Denaro ne parlò con Vincenzo Sinacori allora picciotto emergente della mafia mazarese, i due, ha ricordato Sinacori una volta diventato collaboratore di giustizia, discussero di quel delitto passeggiando in mezzo ad un agrumeto. Sinacori si è anche autoaccusato del delitto di Vito Lipari. Ubbidì ad un ordine, non ha mai saputo dire il perché. Una delle piste del delitto Lipari conduce ad un «segnale» (di morte) mandato dalla cupola di Cosa Nostra alla “famiglia” degli esattori Salvo ai quali Lipari, esponente di punta della Dc, primo dei non eletti alla Camera (45 mila voti di preferenza), era «politicamente» legato. Un’altra traccia conduce al «sacco» del Belice, al post terremoto, agli interessi che gravavano su una parte del piano di ricostruzione, quello che riguardava la zona di Castelvetrano, il cosidetto IV comprensorio: interessava 10 Comuni e 80 mila ettari. Ci sarebbero state due planimetrie, una quella ufficiale, l’altra quella voluta dai «mammasantissima», terreni sui quali non si doveva costruire, si è invece costruito, terreni che hanno preso per questa ragione grande valore.
Una interminabile ferita lunga 45 anni. Il Belice che nel 1968 trema mettendo ferite su ferite già esistenti. La povertà, il degrado, l’abbandono che già devastava questa terra, martoriati da un terribile terremoto, era il 15 gennaio 1968. Un solco profondo rimasto ancora oggi non colmato, sporco di tanto sangue, le vittime del sisma e a seguire il sangue dei morti ammazzati per consentire alla mafia di affondare le sue mani nell’affare ricostruzione. Dentro al post terremoto ci sono le faide, le vendette, gli scandali, ancora oggi più o meno risolti o rimasti avvolti nel mistero, come d’altra parte sono rimasti certi omicidi che hanno avuto come scenario intrallazzi, gli affari illeciti, e, per l’appunto anche i delitti. Come quello dell’ex sindaco di Castelvetrano Vito Lipari, ucciso il 13 agosto del 1980. Un delitto rimasto senza colpevoli e senza movente. Mauro Rostagno dagli schermi di Rtc non perdeva una sola delle udienze del primo processo per il delitto Lipari, quello che vedeva imputato il capo mafia di Mazara Mariano Agate assieme a boss catanesi: fu durante una pausa di una udienza di questo dibattimento che Agate mandò a dire, da dentro la gabbia, che Rostagno «doveva dire meno minchiate» sul suo conto. Rostagno continuò a parlare di quel processo e a ricostruire le trame della mafia belicina. Qualche mese dopo Rostagno fu ucciso. La sua morte fu decisa a Castelvetrano da don Ciccio Messina Denaro. Rostagno era una “camurria” e quindi andava ammazzato, don Ciccio Messina Denaro ne parlò con Vincenzo Sinacori allora picciotto emergente della mafia mazarese, i due, ha ricordato Sinacori una volta diventato collaboratore di giustizia, discussero di quel delitto passeggiando in mezzo ad un agrumeto. Sinacori si è anche autoaccusato del delitto di Vito Lipari. Ubbidì ad un ordine, non ha mai saputo dire il perché. Una delle piste del delitto Lipari conduce ad un «segnale» (di morte) mandato dalla cupola di Cosa Nostra alla “famiglia” degli esattori Salvo ai quali Lipari, esponente di punta della Dc, primo dei non eletti alla Camera (45 mila voti di preferenza), era «politicamente» legato. Un’altra traccia conduce al «sacco» del Belice, al post terremoto, agli interessi che gravavano su una parte del piano di ricostruzione, quello che riguardava la zona di Castelvetrano, il cosidetto IV comprensorio: interessava 10 Comuni e 80 mila ettari. Ci sarebbero state due planimetrie, una quella ufficiale, l’altra quella voluta dai «mammasantissima», terreni sui quali non si doveva costruire, si è invece costruito, terreni che hanno preso per questa ragione grande valore.
Cosa c’entra il sindaco Lipari ammazzato dalla mafia in tutto questo? Pare che lui fosse in possesso delle due cartografie, quindi ucciso perchè risultato per la mafia «troppo informato di cose che non doveva sapere». Oppure perché diventato un «complice» troppo ingombrante. Difficile tanti anni dopo avere la verità, il «silenzio» anche in questo caso ha fatto sparire tutto, quelle cartografie, assieme alla memoria e al ricordo. Lipari non era un politico qualsiasi: sindaco, presidente dell’ospedale di Castelvetrano, presidente e dirigente del consorzio per lo sviluppo industriale di Trapani.
La cronaca di 33 anni addietro. Ore 9,15 del 13 agosto 1980. Vito Lipari usciva dalla sua villa sul litorale di Triscina, a pochi chilometri da Castelvetrano, si mette alla guida della sua auto diretto al municipio. L’auto dei killer gli si affianca all’uscita di una curva, Lipari se ne accorge pochi istanti prima che gli assassini – tre, forse quattro persone – aprano il fuoco contro di lui. Vito Lipari resta fulminato; l’ultima revolverata, il colpo di grazia, gliela esplodono a pochi centimetri dalla faccia, per sfigurarlo. A poche ore dal delitto i carabinieri fermano 4 persone: Nitto Santapaola, boss catanese, Mariano Agate, boss mazarese, e ancora Francesco Mangione e Rosario Romeo. Santapaola per arrivare a Castelvetrano violò la sorveglianza speciale, perché correre il rischio di essere arrestato: “Sono qui per comprare meloni, cocomeri…da Mariano Agate2. Rostagno durante il processo sbeffeggiò questa dichiarazione, “Mariano Agate vende cemento (titolare di un impianto a Mazara) mica cocomeri”. Santapaola stese poco in cella di sicurezza, nonostante risultò positivo al guanto di paraffina, Santapaola grazie ad un riscontro “miracoloso” di un carabiniere, il capitano Vincenzo Melito, aveva sparato ma perché 24 ore prima del suo fermo aveva partecipato ad una battuta di caccia. Melito certificò il falso e fu ricompensato, a lui fu intestata da Santapaola l’auto sulla quale i quattro erano stati fermati, una fiammante Renault 30 TX immatricolata dalla Pam Car di Catania, la concessionaria di Santapaola. Il capitano Melito aveva trovato riscontro alla dichiarazione di Santapaola nell’alibi fornito dal titolare della tenuta, uno dei cavalieri del lavoro di Catania, Gaetano Graci, uno dei potenti della Sicilia, potente perché “socio” della mafia. Graci catanese lavorava nel trapanese, costruiva case popolari finanziate con i soldi del terremoto. Al termine del dibattimento di primo grado, la Corte d’Assise di Trapani con sentenza emessa l’11 giugno 1988 dichiarò gli imputati responsabili dei delitti loro ascritti e condannò l’AGATE, il SANTAPAOLA, il MANGION e il ROMEO all’ergastolo e RISERBATO Antonino a ventinove anni di reclusione. La Corte di primo grado ritenne inverosimile la giustificazione addotta dagli imputati sulla presenza dei Catanesi nel mazarese. Costoro, infatti, asserirono che il SANTAPAOLA aveva la necessità di acquistare meloni e pomodori e che a tal fine aveva contattato l’AGATE e si era fatto accompagnare dal MANGION e dal ROMEO. I Giudici reputarono inoltre significativi il comportamento sospetto tenuto dagli imputati quando si accorsero del posto di blocco e concretatosi nell’immissione in una stradina laterale nel tentativo di evitare i militari e la circostanza che i medesimi si trovavano su una strada che era la prosecuzione naturale della via di fuga (direzione Castelvetrano) intrapresa dagli assassini, poiché tutti i possibili percorsi tra i tre punti cardine della vicenda (luoghi dell’omicidio, dell’abbandono della FIAT 128 rossa e del controllo dei prevenuti) avevano sbocco sulla statale 115.
La decisione di primo grado venne riformata dalla Corte d’Assise d’Appello di Palermo, che con sentenza pronunciata il 16 luglio 1992 e passata in giudicato il 17 febbraio 1993 prosciolse i prevenuti per non avere commesso il fatto.
Il maxi processo Omega (il delitto Lipari nelle pagine della sentenza). Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Vincenzo Sinacori e Antonio Patti individuarono altri responsabili rispetto a quelli originariamente processati. Sulla base delle dichiarazioni rese da Antonio PATTI e Vincenzo SINACORI, gli stessi sono stati rinviati a giudizio per avere cagionato con premeditazione la morte di Vito LIPARI in concorso con GANCITANO Andrea, LEONE Giovanni e NASTASI Antonino, oltre che con CAPRAROTTA Francesco, CLEMENTE Giuseppe e MESSINA Francesco, deceduti – Giuseppe Clemente, classe 27 era un pezzo da 90, padrino di battesimo di Rosalia Messina Denaro, figlia di don Ciccio il patriarca mafioso del Belice e sorella di Matteo, il super latitante alla macchia da 20 anni – Vincenzo SINACORI ha confessato di avere partecipato all’omicidio di Vito LIPARI. Ha affermato che fu il suo amico GANCITANO a coinvolgerlo, per consentirgli di diventare lui stesso una “persona di rispetto”. Il collaboratore, infatti, pur non sapendo che molte delle persone che partecipavano allo sbarco delle sigarette di contrabbando sul litorale mazarese erano mafiose, riteneva che fossero soggetti rispettabili e si accorgeva che la gente voleva loro bene, perchè avevano un comportamento irreprensibile. La mattina dell’omicidio il SINACORI e il GANCITANO, il quale la sera precedente aveva avvisato l’amico che quel giorno sarebbero dovuti andare a Castelvetrano, partirono da Mazara del Vallo diretti in quel paese a bordo della Golf diesel del secondo. Il GANCITANO durante il tragitto comunicò all’odierno collaboratore che stavano recandovisi al fine di commettere un omicidio per fare un piacere ai Castelvetranesi. A quell’epoca il SINACORI non conosceva nessuno di quest’ultimo paese, con la sola eccezione, forse, di Pino CLEMENTE il vecchio, il quale talvolta era andato alla cantina di Mariano AGATE. Infatti gli unici contatti che aveva avuto con “uomini d’onore” che non fossero mazaresi erano stati in occasione degli sbarchi di sigarette, che compivano insieme ai Marsalesi. Quando il GANCITANO gli rivelò la ragione della trasferta, il collaboratore non reagì, poichè da un lato era amico di quest’ultimo e dall’altro lato gli piacevano le persone che il medesimo frequentava. Andarono in una fattoria di campagna in zona Belvedere, nell’agro di Castelvetrano, nella quale Pino CLEMENTE accudiva ai suoi animali. Il GANCITANO scese dalla macchina ed entrò in una casetta che era là, mentre il SINACORI attese in automobile. In seguito il GANCITANO uscì insieme a LEONE Giovanni, MESSINA Francesco, CLEMENTE Giuseppe il vecchio e NASTASI Antonino, il quale ultimo non era noto al collaboratore. Il propalante ha proseguito il suo racconto affermando che l’agguato avvenne circa alle ore 8,30-9,00 del mattino, mentre il LIPARI stava recandosi da Triscina, località balneare, a Castelvetrano, per ragioni connesse alla sua carica. Egli si mise alla guida di una FIAT 128 rossa, che (a quanto successivamente gli raccontarono il MESSINA o il LEONE) era stata rubata dai Marsalesi, il LEONE salì al suo fianco, il GANCITANO e il NASTASI si posizionarono nel sedile posteriore rispettivamente sul lato destro e su quello sinistro. Quest’ultimo rimaneva abbassato per evitare il rischio che qualcuno lo riconoscesse, dato che era originario di Castelvetrano e nella stagione estiva la strada era trafficata, essendo Triscina una località balneare. Il LEONE aveva un fucile a canne mozze e il GANCITANO un revolver, che erano stati procurati dai Castelvetranesi. Il gruppo di fuoco si diresse a Triscina. Attuarono il piano che era stato predisposto: la macchina con a bordo i killer si portò in una traversa della strada che da Triscina portava a Castelvetrano, che la vittima designata era solita percorrere. MESSINA Francesco era nei pressi, a bordo della sua FIAT 127 bianca, con una funzione di appoggio. Dopo che tre suoni di clacson ebbero segnalato che l’autovettura dell’obiettivo si stava avvicinando, essi si immisero nella strada che da Triscina portava a Castelvetrano, lasciarono passare l’autovettura e -dopo che il NASTASI ebbe loro confermato che si trattava del LIPARI- si affiancarono alla Golf e la superarono. In questi ultimi attimi il LEONE gli sparò con il fucile a canne mozze e il GANCITANO fece lo stesso con il revolver. Il LIPARI fu colpito dalla prima fucilata e perse il controllo della macchina, che si fermò in una cunetta lì vicina, ubicata nei pressi di una curva. Il LEONE scese e sparò alla vittima il colpo di grazia con un revolver calibro 38. Non appena il killer fu risalito sulla macchina, che era rimasta accesa, il gruppo di fuoco ripartì; tuttavia il motore dell’autovettura, che era vecchia, stava per spegnersi e non lo fece perchè il LEONE ebbe la prontezza di riflessi di tirare l’aria. Il gruppo di fuoco ritornò nella fattoria del CLEMENTE, dove i componenti dello stesso si separarono: il NASTASI rimase lì; il LEONE salì sulla FIAT 127 del MESSINA, il GANCITANO si mise alla guida della sua Golf e il SINACORI si assunse il compito di portare la FIAT 128 a Mazara del Vallo. Tuttavia, sulla strada che dal Belvedere portava al boschetto Antalbo quest’ultimo veicolo si bloccò definitivamente ed egli montò a bordo della Golf del GANCITANO, il quale lo seguiva. Il collaboratore non provvide personalmente a bruciare l’autovettura, ma MESSINA Francesco o qualcun altro gli disse che era stata incendiata. Il SINACORI ha concluso dicendo che non conosceva il LIPARI, ma alle precedenti elezioni avevano avuto l’indicazione di votare per lui, che era risultato il primo dei non eletti. Egli, infatti, anche se all’epoca non era affiliato, era già vicino alla “famiglia” e ne riceveva i dettami (cfr. esame del SINACORI all’udienza del 15 aprile 1998, nonché controesame e riesame effettuati il 12 maggio 1999, nei quali ha confermato e specificato quanto affermato nella prima sede). Antonio PATTI ha riferito che nei primi anni ‘80 fu incaricato da Vincenzo D’AMICO di rubare una macchina a quattro sportelli e che eseguì l’ordine asportando una FIAT 128 bianca a quattro sportelli da via Mario Rapisardi, che è una traversa che si diparte da via XI Maggio sulla destra, poco prima che essa sbocchi in Piazza della Repubblica. L’automobile era in un posteggio, in cui potevano trovare posto una ventina di veicoli, ubicato di fronte a un palazzo con l’ascensore e circa quaranta metri dopo l’albergo Stella e la pasticceria DI GAETANO. Commise il reato sforzando il deflettore dello sportello, penetrando nell’abitacolo e mettendo in moto la vettura con una chiave che serviva per aprire le scatolette di carne Simmenthal. Il PATTI ha aggiunto che -dopo essere andato a riferire al D’AMICO e al CAPRAROTTA che aveva rubato l’autovettura ed essersi recato con costoro in campagna a prendere una doppietta calibro 12 a canne mozze- andò a riprendere la FIAT 128 che aveva occultato. Quindi i tre uomini si recarono nella fattoria di Pino CLEMENTE, sita nell’agro di Castelvetrano nei pressi dell’ingresso del paese, e consegnarono a costui il veicolo e l’arma, ritornando poi a Marsala. Il PATTI ha affermato altresì che, pur non essendo stato informato di nulla, aveva capito che il fucile e l’autovettura sarebbero stati usati per uccidere qualcuno, tanto che alcuni giorni dopo, leggendo sul Giornale di Sicilia che era stato assassinato Vito LIPARI, il Sindaco di Castelvetrano, collegò immediatamente i fatti…con riferimento alla causale del delitto, la Corte di Assise del maxi processo Omega, ha ritenuto di c ondividere le considerazioni contenute nella più volte citata sentenza della Corte d’Assise di Trapani, nella quale il movente del delitto è stato individuato nella collocazione politica della vittima in uno schieramento all’epoca vicino alla fazione opposta rispetto a quella degli emergenti “corleoesi”. Nella suddetta decisione, infatti, si è sottolineato come l’ucciso fosse legato sia sotto il profilo politico che personale ai cugini SALVO di Salemi, i quali del resto non negarono mai la circostanza, ammettendo anzi di averne cospicuamente finanziato la campagna elettorale del 1979, nella quale il LIPARI risultò il primo dei non eletti con ben 46.000 preferenze. Il maxi processo però è pervenuto all’assoluzione degli imputati, perfettamente credibile il racconto di Sinacori, insufficiente però per le condanne la cosidetta “mono chiamata”.
Il summit Agate/Santapaola. Quel giorno di agosto di 33 anni addietro stava però accadendo altro. Era previsto, e lo si fece, un vertice tra i mafiosi di Mazara e quelli di Catania, da qui il fatto di avere trovato insieme Mariano Agate e Nino Riserbato co i catanesi Nitto Santapaola, Francesco Mangion e Franco Romeo. Si dovevano vedere per mettere a posto alcune questioni, come i danneggiamenti che in quel periodo subiva l’imprenditore catanese Graci. Agate e Santapaola seppero mettere fine a questi “incresciosi” episodi. Mentre altri killer ammazzavano Vito Lipari.