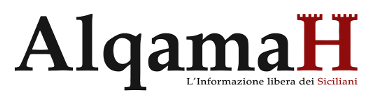L’ultimo corleonese, l’ultimo stragista. Così oggi leggiamo oggi ancora di piùà nel giorno della sua morte, di Matteo Messina Denaro, 61 anni, capo mafia di Castelvetrano, e di due quarti della Sicilia (se si considera il ruolo di monarca mafioso della provincia di Trapani e di parti delle limitrofe province di Palermo e Agrigento). Ma i Messina Denaro sono molto di più, le chiavi delle casseforti nelle mani di Matteo, le stesse insanguinate dai tanti morti ammazzati “da riempierci un cimitero”, raccontava al suo fidato Francesco Geraci, diventato poi collaboratore di giustizia e anche lui come il capo morto di recente per un tumore al colon. Nel raccontare oggi la mafia trapanese dobbiamo partire dalla lezione che ci hanno lasciato Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che con Cosa nostra trapanese avevano fatto bene i conti. Falcone iniziò a Trapani la sua carriera in magistratura imbattendosi nella mafia del dopoguerra rappresentata dal bandito Mariano Licari, dentro certi salotti anni dopo ebbe la consapevolezza di cosa era la mafia borghese: Borsellino fu procuratore a Marsala, vi approdò con quell’ingiuria, ancora oggi usata, di essere un “professionista dell’antimafia”, l’unica cantonata letterari di Leonardo Sciascia che ebbe questo titolo a un uso articolo dopo la nomina di Borsellino a capo di quella procura. Cosa nostra di questo disappunto certamente non se ne dispiaceva. Negli anni chi l’ha attaccata è sempre stato nella messaggistica mafiosa un “professionista dell’antimafia”.
L’ultimo corleonese, l’ultimo stragista. Così oggi leggiamo oggi ancora di piùà nel giorno della sua morte, di Matteo Messina Denaro, 61 anni, capo mafia di Castelvetrano, e di due quarti della Sicilia (se si considera il ruolo di monarca mafioso della provincia di Trapani e di parti delle limitrofe province di Palermo e Agrigento). Ma i Messina Denaro sono molto di più, le chiavi delle casseforti nelle mani di Matteo, le stesse insanguinate dai tanti morti ammazzati “da riempierci un cimitero”, raccontava al suo fidato Francesco Geraci, diventato poi collaboratore di giustizia e anche lui come il capo morto di recente per un tumore al colon. Nel raccontare oggi la mafia trapanese dobbiamo partire dalla lezione che ci hanno lasciato Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che con Cosa nostra trapanese avevano fatto bene i conti. Falcone iniziò a Trapani la sua carriera in magistratura imbattendosi nella mafia del dopoguerra rappresentata dal bandito Mariano Licari, dentro certi salotti anni dopo ebbe la consapevolezza di cosa era la mafia borghese: Borsellino fu procuratore a Marsala, vi approdò con quell’ingiuria, ancora oggi usata, di essere un “professionista dell’antimafia”, l’unica cantonata letterari di Leonardo Sciascia che ebbe questo titolo a un uso articolo dopo la nomina di Borsellino a capo di quella procura. Cosa nostra di questo disappunto certamente non se ne dispiaceva. Negli anni chi l’ha attaccata è sempre stato nella messaggistica mafiosa un “professionista dell’antimafia”.
I due magistrati, Falcone e Borsellino, segnavano una profonda differenza tra la mafia palermitana e quella trapanese: la prima, dicevano, era quella militare, la seconda quella economica. La prima è stata più facile da colpire, ma non è sconfitta e non finisce nelle tombe come i boss; la seconda ancora primeggia nonostante arresti, condanne e decine di provvedimenti di confisca, che nel trapanese superano il cinque miliardi di euro. A Trapani la mafia economica è rimasta nelle mani di Matteo Messina Denaro, sin da prima di quel 1993, anno dell’inizio della sua latitanza, cominciata, col padre, il padrino del Belìce, don Ciccio Messina Denaro, nella canonica di una chiesa di Calatafimi, dove un sacerdote si prendeva anche cura dei beni archeologici frutto degli atti predatori dell’anziano don Ciccio Messina Denaro.
Il brutto bruco della mafia assassina si è chiuso dentro una crisalide dalla quale è uscita la farfalla della mafia non violenta che, sotterrate le armi, usa la corruzione e vende i suoi voti. La mafia delle imprese e delle banche a Trapani ha trovato un humus perfettamente adatto al suo sviluppo. Trapani la città di certe banche e banchieri. Sulla Banca Sicula della famiglia D’Alì, grandi latifondisti e datori di lavoro dei Messina Denaro, campieri nei loro terreni di contrada Zangara di Castelvetrano, il cui esponente più noto è l’ex senatore e sottosegretario all’Interno dal 2001 al 2006 Antonio D’Alì – in carcere ad Opera da dicembre scorso per scontare una condanna a sei anni per concorso esterno in associazione mafiosa – indagò nel 1991 il vice questore Rino Germanà, due anni dopo scampato a un agguato organizzato da Bagarella, Graviano e Messina Denaro. Più recente il caso della Cassa rurale di Paceco, finita nel 2016 sotto amministrazione giudiziaria per l’ipotesi di collegamenti con la massoneria e alcuni soggetti pregiudicati per reati di mafia. Trapani, città delle finanziarie dove si sarebbe raccolto denaro sporco che – ripulito – è servito come garanzia per i mafiosi presso le city finanziarie europee. Nei primi anni 2000 la mafia era pronta a lanciare una banca tutta sua, ma l’operazione è stata mandata all’aria da un’indagine della Squadra mobile guidata dall’odierno direttore del Servizio centrale anticrimine, Giuseppe Linares, e coordinata dal pm Andrea Tarondo, una di quelle intelligenze investigative più attente al fenomeno mafioso, di fatto spinto a occuparsi oggi di ben altro, all’estero, lontano dall’Italia.
Qui la mafia non è la Cosa nostra dei viddani, ma la mafia dei borghesi. Esempi? Il medico Melchiorre Allegra, specialista in malattie infettive e boss, in epoca fascista finì arrestato e confessò l’esistenza dell’organizzazione mafiosa. Oppure l’imprenditore trapanese Totò Minore, uomo d’onore che viveva con il rispetto di una intera città, presidente della squadra di calcio, tra i protagonisti del sacco edilizio della città e contrario alla presenza nel suo territorio delle raffineria di droga dei corleonesi di Riina, che per questo volle la sua morte nel novembre 1982. E sempre imprenditori con buone frequentazioni sono stati gli ultimi accertati capi, Vincenzo Virga e Francesco Pace, tutt’altro che viddani.
Questa mafia ha sempre avuto una precisa capacità della sommersione che funziona ancora oggi. È tanto legata alla massoneria da averne assorbito anche le caratteristiche organizzative. Mafiosi affiliati alla massoneria ne esistono tanti, ma il più importante fu il mazarese Mariano Agate tra gli iscritti alla loggia segreta C creata all’interno del circolo culturale capeggiato da un professore di filosofia, Gianni Grimaudo. Un circolo ben frequentato, anche da magistrati e giudici, pronti a colpire il lavoro onesto di loro colleghi, alcuni dei quali uccisi da Cosa nostra, come Gian Giacomo Ciaccio Montalto.
Non c’è indagine ancora oggi condotta dalla procura di Trapani che non si imbatta in personaggi della massoneria. In Tribunale è in corso il processo denominato Artemisia, imputati di aver creato una loggia segreta un pugno di politici di Castelvetrano, capeggiati da un ex deputato Giovanni Lo Sciuto, amico di gioventù di Messina Denaro. E ci sono inchieste che oggi dimostrano come la magistratura continui ad avere un ventre molle che permette pericolose infiltrazioni: non si spara più, ma ancora oggi finiscono nell’occhio del ciclone i magistrati che lavorano correttamente e non i traditori o i corvi. Inoltre partendo da Trapani e girando per la Sicilia, fermandosi a Capaci, dove la resistenza a Cosa nostra non pare essere quella che appare, è ancora oggi facile imbattersi in investigatori preparati finiti sotto accusa proprio le loro qualità. Come accadde al Bellodi uscito dalla penna di Leonardo Sciascia.
A Trapani ci sono i colletti bianchi che parlano di Messina Denaro come di una persona da adorare e venerare. Un boss da far sindaco o addirittura premier. Questa non è una terra normale. Sembra di essere dentro la sceneggiatura della Piovra televisiva , non a caso scritta da un trapanese, Nicola Badalucco. Spingere la polvere sotto i tappeti resta l’esercizio più comune, poi scatta sempre il piagnisteo che di Trapani si parla sempre e comunque male, come se qui il male non sia mai allignato. Siamo nella moderna Mafiopoli di Peppino Impastato. Cinisi è tornata a vivere a Trapani, “Gommopoli” dove tutto rimbalza e sparisce. Certi sindaci per anni hanno detto che Matteo Messina Denaro non è il primo dei problemi, figurarsi cosa diranno oggi che è il boss è morto..
Gommopoli-Trapani resta il luogo ideale per coltivare equivoci che danno forza alla “nuova” mafia. La città si prospetta non sempre in modo lucido dinanzi a una mafia capace di invadere la politica, la pubblica amministrazione e l’economia. La lotta contro Cosa nostra più che a Palermo si combatte qui, dove si sequestrano e confiscano i beni, dove i politici continuano a non rispettare la “distanza di sicurezza dai mafiosi” e “dalla massoneria”, sale della minestra preparata in stanze segrete, servita ai trapanesi come la migliore e invece la più avvelenata.