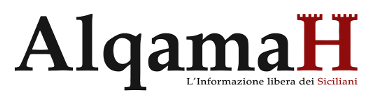100 articoli verso il 21 Marzo: il tema del lavoro e dei lavoratori nelle aziende confiscate
Sono radicalmente convinta che per affrontare lo studio delle mafie sia necessario partire da un approccio storico che permetta di individuare quelle strategie di gestione del potere che hanno permesso alla criminalità organizzata di superare ogni ostacolo posto da uno Stato, o meglio, da uomini dello Stato, che nel corso degli ultimi cent’anni hanno svolto un’azione instancabile indirizzata al defaticamento di una forza malvagia che è riuscita a dominare territori con latitudini sempre più estese.
Qualche flash:
 Il primo movimento antimafia prende vita alla fine del 1800 nelle campagne siciliane e si propone di rinnovare i rapporti di lavoro agricolo che all’epoca prevedeva diversi sistemi di ripartizione del prodotto, ma che si riduceva ad un impianto molto simile alla schiavitù per debito, al quale il contadino era condannato per la vita intera. I Fasci Siciliani rappresentano un’organizzazione di lotta per la giustizia sociale e per questo motivo vennero stroncati sanguinosamente.
Il primo movimento antimafia prende vita alla fine del 1800 nelle campagne siciliane e si propone di rinnovare i rapporti di lavoro agricolo che all’epoca prevedeva diversi sistemi di ripartizione del prodotto, ma che si riduceva ad un impianto molto simile alla schiavitù per debito, al quale il contadino era condannato per la vita intera. I Fasci Siciliani rappresentano un’organizzazione di lotta per la giustizia sociale e per questo motivo vennero stroncati sanguinosamente.
Nel secondo dopo guerra, proprio negli stessi territori dei Fasci, un sontuoso movimento sindacale fu protagonista della più importante rivendicazione contro lo sfruttamento del lavoro e all’insegna della riforma agraria mediante l’applicazione dei decreti Gullo che prevedeva l’assegnazione delle terre incolte o mal coltivate ai contadini che ne facevano richiesta. Una vera carneficina: 000
 Tra il 1959 e il 1963 il consiglio comunale di Palermo concesse 4.205 licenze edilizie rendendo l’assessorato ai Lavori pubblici la più impudente e lucrosa fonte di potere clientelare in Italia. Licenze in cambio di tessere di partito. Siamo negli anni del Sacco di Palermo. Il lavoro veniva barattato con il voto. Allora era già chiaro che lo scambio non veniva solo con il denaro, ma con “altre utilità”.
Tra il 1959 e il 1963 il consiglio comunale di Palermo concesse 4.205 licenze edilizie rendendo l’assessorato ai Lavori pubblici la più impudente e lucrosa fonte di potere clientelare in Italia. Licenze in cambio di tessere di partito. Siamo negli anni del Sacco di Palermo. Il lavoro veniva barattato con il voto. Allora era già chiaro che lo scambio non veniva solo con il denaro, ma con “altre utilità”.
A seguire la mafia che dal latifondo allargava i suoi tentacoli all’affare del cemento e che dal controllo dei pozzi d’acqua, controllava i cantieri edilizi, c’era un giovane Pio La Torre che da quell’esperienze, prima come sindacalista e poi come consigliere comunale, comprese appieno le dinamiche del potere mafioso, al punto tale da riuscire a descriverle perfettamente in una fattispecie di reato: il 416 bis.
A 35 anni da quel 13 settembre del 1982, data di emanazione della legge Rognoni-La Torre, in tutto il Paese, senza distinzione tra Sud e Nord, tra economie floride e primarie, tra tradizioni storiche culturali di resistenza o rassegnazione, la mafia si infiltra nei territori e ne diventa sistema. Interi settori vengono monopolizzati. Non ci sono più solo i classici settori tradizionalmente più vulnerabili contraddistinti da un basso livello tecnologico e con una forte presenza di unità produttive di piccola scala, come l’edilizia e il movimento terre, i trasporti e le infrastrutture. Non ci sono solo le strutture aziendali agili da costituire e da gestire. La mafia controlla dal turismo all’hi–tech e acquista quote azionarie di grandi società quotate in borsa.
Ma la sua estensione verso l’alto non le fa abbandonare le salde radici al terreno. Non si dimentica mai dei propri amici, delle proprie alleanze. Di creare quel bacino di consenso, mediante la concessione di posti di lavoro, che le permette di controllare l’economia di un Paese, usurpandone la dignità, violandone la libertà.
 L’azienda mafiosa crea un’economia malata a vantaggio solo dei propri alleati e a discapito di un intera collettività e di quei cittadini che vorrebbero contribuire alla crescita della propria comunità mediante una attività imprenditoriale, ma che si trovano schiacciati da una concorrenza spietata che non conosce legalità, rispetto per l’ambiente, tutela del lavoro.
L’azienda mafiosa crea un’economia malata a vantaggio solo dei propri alleati e a discapito di un intera collettività e di quei cittadini che vorrebbero contribuire alla crescita della propria comunità mediante una attività imprenditoriale, ma che si trovano schiacciati da una concorrenza spietata che non conosce legalità, rispetto per l’ambiente, tutela del lavoro.
In un quadro così sconfortante l’unico strumento che sembra riuscire a colpire l’estensione delle mafie proviene da quelle lotte contadine del II dopo guerra, dai controlli degli appalti palermitani, dalle proposte normative contenute in nuce nella relazione di minoranza della Commissione Parlamentare antimafia del 1976. Quello strumento è previsto dal comma 7, art. 416 bis, della legge Rognoni-La Torre: la confisca obbligatoria dei beni del mafioso.
Beni che possono essere mobili, immobili o aziende. E che, in base al codice antimafia, hanno una diversa destinazione: confluire al Fondo Unico Giustizia, essere utilizzati per finalità istituzionali o sociali o venire affittati, venduti o liquidati. L’aggressione patrimoniale, con l’annessa ablazione dei beni, rappresenta solo la fase iniziale del percorso di riscatto di una collettività che non trova affrancamento, se non mediante una rinascita di questi beni che da mafiosi divengono beni comuni. E qual è lo strumento principe per una collettività se non quella di autoproclamarsi artefice del proprio destino, della propria economia, del proprio benessere e della tutela del proprio ambiente, attraverso il quale il cittadino diventa parte integrante della comunità? Il lavoro. Un lavoro che non è semplicemente uno strumento per procacciarsi denaro, ma è forma di partecipazione sociale e di gratificazione personale. Attraverso il lavoro l’uomo trova un ruolo nella società. La mafia lo ha sempre saputo ed ha da sempre utilizzato il lavoro come strumento di ricatto, di scambio e di sfruttamento. Dalla gestione del latifondo siciliano, alle imprese nella pianura reggiana: sfruttamento dei contadini che lavoravano la terra e operai sottoposti a regime di caporalato. Ed allora, alla base di una seria azione di contrasto alla criminalità organizzata deve esserci la volontà di estirpare lo sfruttamento dei lavoratori ai quali non viene riconosciuta la dignità del proprio lavoro, ma che vengono utilizzati come armi di una produzione economica che impoverisce il proprio territorio, come strumenti utilizzati dall’imprenditore mafioso che, a fronte di un misero stipendio concesso come favore, non riconosce alcuna tutela.
 Se l’impresa mafiosa avvelena il mercato, il primo mercato che viene colpito è quello del lavoro. Di conseguenza, se lo Stato, mediante l’aggressione dei beni, toglie all’impresa mafiosa il potere di controllo dell’economia, quello Stato deve essere in grado di riacquistare spazi nei quali i cittadini possano crescere come parte integrante di una economia pulita. Non basta strappare attività economiche ai mafiosi, è necessario riconsegnare quell’economia alla collettività, riconoscendo gli strumenti affinchè la trasformazione “da mafiosa a libera” sia realizzabile.
Se l’impresa mafiosa avvelena il mercato, il primo mercato che viene colpito è quello del lavoro. Di conseguenza, se lo Stato, mediante l’aggressione dei beni, toglie all’impresa mafiosa il potere di controllo dell’economia, quello Stato deve essere in grado di riacquistare spazi nei quali i cittadini possano crescere come parte integrante di una economia pulita. Non basta strappare attività economiche ai mafiosi, è necessario riconsegnare quell’economia alla collettività, riconoscendo gli strumenti affinchè la trasformazione “da mafiosa a libera” sia realizzabile.
Abbiamo imparato da Don Luigi Ciotti che il primo testo antimafia è la Costituzione Italiana che riconosce il lavoro come primo valore identitario della nostra Repubblica. Proprio nell’azione di liberazione dalla dittatura mafiosa lo Stato deve riaffermare questo principio. Quel maltolto ripreso alle mafie deve tornate ad essere fucina di un lavoro pulito, tutelato e tutelante.
Il percorso di restituzione dei beni mafiosi alla collettività è irto di ostacoli. Spesso diventa un meccanismo di equilibrismi normativi e di meri e sterili calcoli di bilancio: si restituiscono palazzi ai comuni che li utilizza per cerimonie ufficiali, ma rimangono scatole semi-vuote per il resto dell’anno, si fanno proseguire attività imprenditoriali senza considerare la loro naturale difficoltà ad agire in un contesto malato e governato da dinamiche corruttive e clientelari.
Raramente al centro di questo percorso di liberazione, perché di questo si tratta, viene messo il lavoro. Un centro sociale o una cooperativa deve dare lavoro, non può basarsi solo sull’attività di volontariato. Un’azienda sequestrata deve poter dare lavoro ai propri dipendenti che non posso essere considerati una parte accessoria, o meri componenti del patrimonio aziendale.
 Nella gestione di una azienda sequestrata, l’amministratore, ma ancor prima lo Stato, che tra l’altro l’amministratore dovrebbe rappresentare, deve fornire tutti gli strumenti affinché il lavoro venga tutelato mediante un buon esercizio dei bilanci. Non il contrario.
Nella gestione di una azienda sequestrata, l’amministratore, ma ancor prima lo Stato, che tra l’altro l’amministratore dovrebbe rappresentare, deve fornire tutti gli strumenti affinché il lavoro venga tutelato mediante un buon esercizio dei bilanci. Non il contrario.
Siamo consapevoli che il costo più alto per l’emersione alla legalità di un’azienda è rappresentato dal “il costo del lavoro”: il pagamento della retribuzione del dipendente nella misura fissata dalla contrattazione collettiva comporterà oneri che, in alcuni contesti, verranno considerati fuori mercato.
L’organico descritto dai libri aziendali, nella maggioranza dei casi, non corrisponderà alla realtà. Vi saranno lavoratori non assunti, ma che lavoreranno in nero; lavoratori assunti, ma che non lavoreranno in azienda e per i quali l’assunzione rappresenta una copertura per attività illegali. I contributi non saranno pagati o, come spesso accade, compresi nella busta paga, ma poi restituiti in contante dai lavoratori.
Proprio per questo motivo, l’attenzione primaria del processo di gestione e amministrazione aziendale deve essere rivolto ai lavoratori e al Lavoro. La creazione di sinergie tra aziende permetterà di distribuire l’organico dei lavoratori in base alle esigenze produttive delle singole realtà. Se in una azienda apparirà sovra-stimato, si cercherà un ricollocamento dell’esubero nei contesti paralleli di zona.
L’azienda non può essere trattata come insieme di macchinari, merce e materia prima. L’azienda è innanzitutto LAVORO. Dal momento in cui l’amministratore entra nel possesso dell’azienda deve rivolgersi ai lavoratori che potranno essere i più fedeli compagni di una lunga avventura. I lavoratori conoscono la loro azienda e possono essere dei validi alleati per comprenderne le dinamiche, quelle virtuose da mantenere e quelle distorte da eliminare. Per questo sarebbe importante condividere con loro le scelte di impresa, anche quelle più dolorose. Perchè sono loro che danno vita all’azienda, che ne sono il cuore. Loro potranno incidere sulla produzione elevandone gli standard e su di loro ricadranno le crisi ed i fallimenti.
Lo Stato, nelle sue diramazioni territoriali, non può ignorare tutto questo. Non può acconsentire gestioni sterili che danneggiano interi territori e tutta la popolazione che su questi vive e produce.
Certo, consegnare abitazioni per l’emergenza abitativa può rappresentare un importante segnale di avvicinamento della comunità allo Stato, ma è nel salvaguardare il lavoro che lo Stato compie la sua missione più alta, quella di dare concretezza al principio democratico sul quale si base la nostra Costituzione.
*docente universitaria Bologna